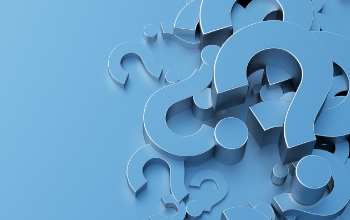Bioetica
Le terapie avanzate, ma più in generale l’innovazione biomedica, portano da sempre con sé grandi quesiti teoretici. A volte mettono letteralmente in crisi i principali modelli interpretativi della bioetica, quasi sempre portano con sé un’ampia gamma di dubbi e domande estremamente pratiche, tra le quali svettano l’informazione e l’allocazione delle risorse. Se da un lato la possibilità dell’editing genomico sugli embrioni umani è probabilmente l’esempio per eccellenza del quesito bioetico del nuovo millennio, dall’altro è impossibile non interrogarsi oggi su temi quali sperimentazione clinica, consenso informato e informazione (sia essa intesa come tempo di cura che come informazione pubblica).
La febbrile ricerca di una nuova terapia, di una nuova speranza per non arrendersi alle malattie, è da sempre connaturata all’uomo. Oggi abbiamo a disposizione sofisticate biotecnologie sviluppate con l’intento di salvare vite umane, che necessitano anni e anni di sperimentazioni cliniche (e prima ancora precliniche) e di ingenti risorse economiche per la loro applicazione pratica. Alle volte sono propriamente in grado di guarire (ne è un esempio la terapia genica per l’immunodeficienza ADA-SCID), in altri casi rappresentano le più alte forme di terapia personalizzata (come le CAR-T). Nella quasi totalità dei casi hanno dei costi elevati, soprattutto se paragonate alla terapie “tradizionali” e richiedono una rielaborazione delle strategie politiche, sociali ed economiche.
Chi può e deve quindi occuparsi di decidere come destinare le risorse, per natura limitate? Chi ha diritto di curare ed essere curato? Siamo certi che si tratti davvero di un problema di costi assoluti? Osservatorio Terapie Avanzate vuole offrire uno spazio di dibattito pubblico dedicato a questi ed altri temi bioetici intrinsecamente pluridisciplinari, accogliendo riflessioni e proposte, senza alcuna pretesa di esaustività. Sempre nell’ottica di farsi strumento al servizio di pazienti, ricercatori, istituzioni, giornalisti e stakeholder, favorendo un dibattito indipendente ed intellettualmente onesto.
Possono servire ad arrivare più in fretta alla fase di commercializzazione ma sollevano importanti implicazioni bioetiche. Lo spiega il prof. Gilberto Corbellini (Roma)
Forse qualcuno ricorda la storia di Jesse Gelsinger, un diciottenne americano che nel 1999 si offrì volontario per una sperimentazione sugli effetti della terapia genica per la cura del deficit di ornitina transcarbamilasi. A quel tempo i Comitati Etici erano molto più severi circa la partecipazione di bambini e giovani, e Jesse - che soffriva di una forma lieve della patologia - si fece avanti e fu inserito nel primo studio clinico per la nuova terapia genica. Studio che gli fu fatale. Tutto questo riporta alla mente quanto sta accadendo oggi nel percorso di sviluppo di un vaccino contro il virus SARS-CoV-2 dal momento che sono migliaia le persone nel mondo che si stanno offrendo volontarie per gli studi clinici.
- Di: Enrico Orzes
La pubblicazione degli esiti del trattamento su un singolo paziente ha sollevato domande circa l’efficacia e i rischi dell’uso di staminali contro questa patologia, e anche questioni bioetiche.
Come ogni racconto che si rispetti, anche quello che ha condotto i ricercatori del McLean Hospital del Massachusetts e del General Hospital di Boston a tentare un trapianto di cellule staminali autologhe per il trattamento di un paziente affetto dal morbo di Parkinson comincia per caso, con l’invio di una e-mail e termina - anche se la fine di questa storia è solo l’inizio di un capitolo più ampio - con la corsa di un’ambulanza nel cuore della notte. I dettagli tecnici di questa storia sono contenuti nell’articolo pubblicato lo scorso 14 maggio sulle pagine della rivista più quotata della medicina, The New England Journal of Medicine, ma si tratta solo della punta dell’iceberg.
- Di: Enrico Orzes
Gli interrogativi emersi in questi ultimi mesi in ambito bioetico sono molteplici e toccano argomenti molto diversi: tra questi, la vendita di trattamenti non autorizzati e l’epidemiologia digitale
I trattamenti non autorizzati a base di cellule staminali fanno capolino anche nell’emergenza sanitaria: a circa due mesi dalla dichiarazione di pandemia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono molteplici le aziende americane che stanno approfittando della situazione disperata per venderle a caro prezzo. Molte cliniche hanno una storia di vendite di questa tipologia di prodotto e, da quando è arrivata la COVID-19, si sono adeguate alle nuove esigenze di mercato, pur mancando le prove scientifiche a sostegno del loro utilizzo. Restando in tema bioetico, sta diventando virale il dibattito legato all’epidemiologia digitale - cioè l’utilizzo di dati generati al di fuori del sistema sanitario pubblico per la sorveglianza delle malattie – soprattutto per quanto riguarda l’omogeneità dell’applicazione delle tecnologie digitali e per la privacy.
- Di: Rachele Mazzaracca
Un gruppo internazionale di esperti si è riunito a Ginevra per parlare di editing genomico e porre in primo piano la giustizia sociale, i diritti umani e le prospettive della società civile
“Come sostenitori dell'interesse generale, esperti di policy, bioeticisti e scienziati, chiediamo un dibattito pubblico sull'editing del genoma umano sulle linee germinali.” Così inizia la dichiarazione di Ginevra, pubblicata a fine gennaio su Trends in Biotechnology. Ad oggi, tutte le dichiarazioni sul tema sono state redatte da gruppi dominati da scienziati e bioeticisti e basate su una prospettiva medico-scientifica. Questa dichiarazione vuole invece orientare il dibattito verso altri ambiti, prendendo in considerazione i contesti sociali, storici e commerciali che potrebbero influenzare lo sviluppo e le applicazioni dell’editing genomico.
- Di: Rachele Mazzaracca